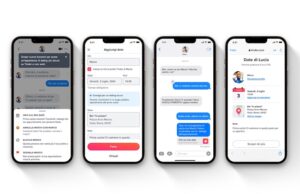Non si è mai visto niente del genere in tv. Niente come The last dance, la serie documentario di Netflix su Michael Jordan e i Chicago Bulls. Lo dovrebbero rendere obbligatorio in quinta liceo, lo dovrebbero proiettare alle conferenze motivazionali, lo dovrebbero prescrivere gli psicologi ai pazienti.
Mi ci sono avvicinato acciuffato dall’hype epifanico che mi ha risvegliato. Nel 1992 i Bulls vincevano il terzo titolo NBA contro Phoenix, io avevo dieci anni e collezionavo le figurine di quelli che erano i miti eterni. Michael Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman. Per un ragazzino non c’erano altro che loro.
Il documentario pare irreale. Racconta la follia di quei giorni. Uno non ci crede che sia successa roba del genere. È solo pallacanestro, tizi che tirano una palla dentro al cesto, chi se ne frega? Eppure li vedi sul parquet che giocano e noti quella precisione, il gesto tecnico, Michael Jordan cazzo, che vola! Vo-la. E la gente esce di testa.
Perché?
C’è qualcosa di antico nel rito orgiastico dello sport. Ai miei tempi al palazzetto dello sport i cori della curva tuonavano: “Tutto il palazzo! Tutto il palazzo!” e la gente batteva le mani. Mi pulsava il cuore, mi entrava nel cervello. Mi emozionava sentire tutta quell’energia.
The last dance parla di questo grande rito collettivo, sciamanico che erano i Chicago Bulls. Fanculo la crisi economica, i poveri, i ricchi, i valori, i ci sono cose più importanti. Lasciateci essere superficiali, lasciateci godere.
The last dance parla anche del lato oscuro di Michael Jordan
E dentro c’è tutto. Anche l’odio.
Arriva piano, distillato con saggezza dal regista che aspetta sei puntate prima di portarci nel lato oscuro del Jordan campione. Scommettitore, bulletto, saccente. Ma Cristo, quello era Dio in terra. Ha tirato fuori da quegli uomini gesti che non sapevano nemmeno di avere. Li prendeva a bastonate, ok, per farli vincere, come Capello. E quindi? Chi siamo noi per entrare nello spogliatoio?
Il fatto è che ci piace entrare nello spogliatoio. Perché facciamo come con i politici, a un certo punto tiriamo fuori che siamo noi a pagargli lo stipendio, noi a comprare i loro gadget, noi a metterci le loro scarpe Air. Quindi sono anche un po’ nostri. L’idolatria è il male. Lo cantava Ferretti: «Non fare di me un idolo, lo brucerò».
La carriera sportiva di Jordan
Michael Jordan passa da essere un niente totale, uno che non si erano nemmeno resi conto che era forte al liceo, al più grande di tutti i tempi nel giro di un anno. La gente esce di testa. Gli danno subito un sacco di soldi, gli dedicano una linea di scarpe (lui voleva l’Adidas ma ahimè gli toccò salvare la Nike), gira spot con Spike Lee. Più famoso di Cristo. E nero oltretutto, ma non si schiera, non fa politica, non gli frega niente di niente, solo di vincere. Questo ci gasa.
Ellroy scrive dell’America anni 50: «La vera trinità di Camelot era: Piacere, Spaccare il Culo e Scopare». L’America di fine anni 80 è la stessa roba, ma DI PIU.
Quindi dopo che Jordan ha resuscitato una squadra che non aveva mai vinto, ha imparato a volare, ha fatto cinquanta punti in partita, ha riportato la gente a tifare… quelli cominciano a odiarlo. Fanculo Jordan gioca 50mila dollari al golf. Fanculo, quello vince troppo. Fanculo, quello è arrogante. E va tutto in caciara. «Se potessi rifare tutto daccapo non diventerei mai un modello. È una partita che perdi sempre, impossibile vincerla. Non sono perfetto» dice MJ.
Alba e tramonto degli dei
Non ricordo chi lo diceva, forse Freud, ma riguardava la distruzione dell’oggetto amato. O li mitizziamo o li distruggiamo. Succede con Jordan. Lo cominciano ad accusare delle peggio cose, gli fanno le pulci, lo paparazzano anche al cesso. Magic Johnson lo dice: se non lo lasciano stare quello mollerà perché gli stanno tutti addosso. Quella fama folle che lo invade è la stessa che due anni dopo farà premere il grilletto a Cobain.
La vita privata di Jordan
Quella fama che abbiamo noi delle vite degli altri, che ci sentiamo come di possederli, che vogliamo recitino per noi gesti che invece noi non abbiamo il coraggio di fare: quello dice tutto del nostro secolo folle. Ecco che ci piombano addosso lo scioglimento dei ghiacci, il virus, la morte, l’inquinamento. Siamo noi sempre a incasinare le cose.
Quindi quanto vedrete la serie The Last Dance non starete vedendo un documentario sul basket, ma la più grande ricostruzione sociologica e antropologica della nostra società negli anni 80 e 90. Siamo noi.
Cosa ci insegna The last dance
Il lato buono è la lezione di dedizione che riceviamo da The last dance e questi uomini. Sarebbero stati dei rifiuti sociali. Rodman uno spacciatore, Pippen al massimo un contadino analfabeta. Sarebbero stati degli zero ma gli piaceva mettere la palla nella cesta. Flushhhh. Il rumore della rete a canestro. Gli stridenti rumori delle scarpe sul parquet. Vizi da viziati, o da ragazzini, fisse. Ma è questo che sono gli sportivi, dei fissati. I piloti fissati della velocità, i calciatori del pallone, i pugili del dolore. E diventano eroi archetipici. I veri uomini vincenti sono quelli che rimangono bambini o che almeno convivono col bambino in loro. E che c’è di più vincente e bambinesco di godere quando la metti dentro da quindici metri sulla linea dei tre punti? Niente.
Guardalo ora
Leggi anche:
Jovanotti e il suo documentario Rai Non voglio cambiare pianeta. Peccato
Il profilo Instagram di Achille Lauro è un inno Millennial alla libertà
Le vecchie partite della Nazionale: la cosa più bella della quarantena italiana